L’invocazione del Doge Nicolò Contarini alla madonna della salute affinché facesse cessare la peste
(Venezia, Basilica di San Marco, 28 ottobre 1630)
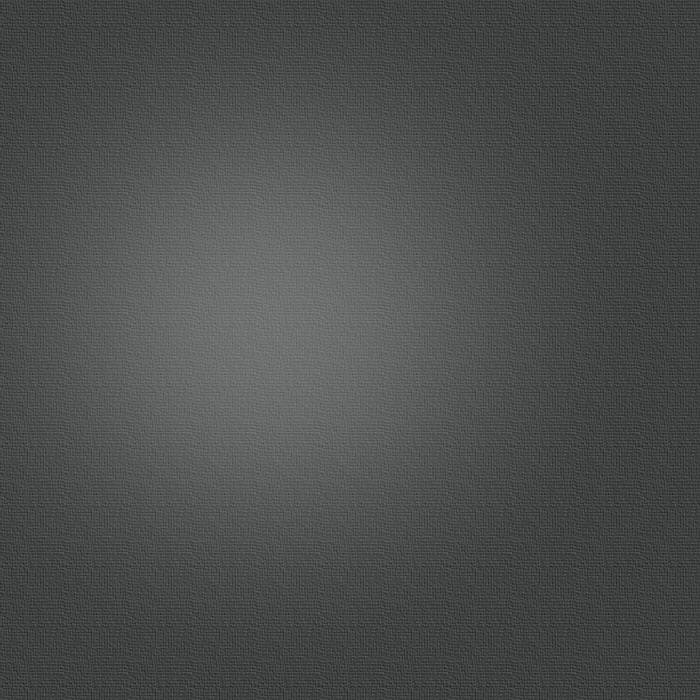





L’invocazione del Doge Nicolò Contarini alla madonna della salute affinché facesse cessare la peste
(Venezia, Basilica di San Marco, 28 ottobre 1630)
Ho pensato di riportare l’invocazione del doge Nicolò Contarini alla Madonna della Salute perché l’ho trovata particolarmente bella e toccante. Per l’occasione ho aggiunto una breve introduzione in forma di racconto per cercare di rendere quello che doveva essere lo stato d’animo dei Veneziani in quel terribile frangente.
Spero vi piaccia.
La Basilica era stipata all’inverosimile, ma non era un giorno di festa: lo dicevano i tanti volti stanchi ed emaciati, gli occhi rossi e gli sguardi tristi e perduti.
No, non era un giorno di festa: nemmeno l’antico profumo d’incenso riusciva a coprire l’odore che stagnava per le strade, un odore orribile, un odore di morte. La peste aveva steso il suo manto nero sulla città di Venezia e l’aveva messa in ginocchio: se cinquant’anni prima la gente aveva cercato di lottare con le unghie e con i denti per sopravvivere, questa volta era subentrato un senso d’impotenza, una triste rassegnazione che, al pari del morbo, aveva contagiato tutti. La medicina aveva fallito e, allora, non era rimasto che rifugiarsi nelle preghiere e nelle processioni. Eppure, nonostante ciò, le barche dei pizegamorti partivano ogni sera colme all’inverosimile, per portare il loro triste carico al Lido.
Il senso di impotenza era giunto fino in Palazzo Ducale, dove il Senato aveva deciso d’intervenire annunciando un voto solenne alla Madonna per implorarla di fermare un tale flagello; e ora il Doge sarebbe venuto lì, a San Marco per impegnarsi davanti al popolo nel luogo più sacro di Venezia di dedicare alla Vergine Maria della Salute un tempio degno e grandioso qualora avesse ascoltato la loro supplica e avesse fatto cessare il morbo.
Quel giorno di fine ottobre la temperatura era ancora mite, eppure dentro la Basilica c’era il gelo, un gelo che penetrava nelle ossa, come capita a chi non sa se riuscirà a vedere il giorno successivo.
Il lontano rullio di tamburi fu accolto da un generale brusio: era il segno che il Doge stava arrivando ma, a mano a mano che il suono si faceva più forte, come per uno strano contrappasso la folla si zittiva, finché non tacque del tutto.
Nicolò Contarini, seguito dalla Signoria, entrò in Basilica e dall’alto delle cantorie si levò un coro soave che pareva rimbalzare tra l’oro dei mosaici ma, nonostante il rilucere di mille candele, l’atmosfera restava mesta.
Il Serenissimo camminava lento, con passo malfermo, anche se cercava di mantenere alta la propria dignità. Per chi lo conosceva, in quegli ultimi mesi pareva invecchiato di cent’anni.
Quando il corteo raggiunse l’altare maggiore, il Patriarca li accolse e ciascuno prese il proprio posto. In quel momento i canti cessarono e la chiesa piombò nel silenzio più totale.
Con uno sforzo evidente il Doge si alzò e, dopo essersi inginocchiato, si levò il corno ducale e lo posò ai piedi della croce. Cercò di alzarsi ma sentì che le gambe gli cedevano; subito uno dei Consiglieri fece l’atto di avvicinarsi per aiutarlo, ma gli bastò uno sguardo per fermarlo. Infine riuscì a risollevarsi e, con passo lento, salì i gradini della tribuna di porfido. Giunto alla sommità, tentò di parlare ma l’emozione gli fece morire le parole in gola; allora rimase così, immobile, con gli occhi serrati sui suoi pensieri, chinando il capo. Quando infine li riaprì, il suo sguardo era limpido, anche se gli occhi erano arrossati. Diede un profondo respiro e poi, alzando gli occhi al Cielo, cominciò a recitare il solenne voto:
“Ave stella del mare, donna delle vittorie, mediatrice di salute e di grazia. Vedi ai tuoi piedi prostrato un afflitto popolo fatto bersaglio al flagello della divina giustizia. La guerra, la pestilenza, la fame, con orribile lotta si disputano a vicenda fra loro le vittime e tutte su noi vogliono trionfo di desolazione, di morte. Mira come i nostri aspetti sparuti dal disagio, lividi dalla malattia, consunti dalle afflizioni, sporgono sotto la pelle le ossa spogliate: vedi come i nostri passi vacillano, come si dilegua il coraggio della nazione estinguendosi il rampollo di tante illustri famiglie. Saran dunque perduti i monumenti delle nostre imprese? saranno inutili le conquiste fatte in tuo nome? diverranno deserti, solinghi questi edifizi, magnifici testimoni del consiglio e del valore dei nostri padri? Quei nemici, che a noi son tali, perché son tuoi nemici, esulteranno del nostro pianto, sovrasteranno alla nostra debolezza, e i nostri petti, non più riscaldati col sangue di tanti prodi, deboli scudi diverranno per opporsi ai progressi dei loro attentati? Vergine Madre se nel tuo nome venne fondata questa patria, se i nostri cuori furono sempre a te devoti, se tante prove ci desti di patrocinio, di protezione, deh! esaudisci le nostre preci, ricevi le supplicazioni di un popolo sofferente. Siamo peccatori, è vero, e perciò a Te ricorriamo, come a nostro rifugio; prega per noi il Divin tuo Figliuolo, faccia salvi gli eletti suoi, scacci, allontani, annìchili, estirpi la tremenda lue, che contamina le nostre vene, che miete tante vite, che desola i servi tuoi: al lampo benefico della tua grazia l’anima nostra commossa intonerà l’inno di laudazione, e col coro de’ celesti confesseremo le glorie Tue ed il santo nome di Dio. Ricevi l’umile offerta di un tempio, sulle vaste pareti del quale vogliamo che i secoli avvenire scorgano impressi i tratti della nostra religione, e dove i successori nostri ed i posteri perpetuamente tributeranno annui rendimenti di grazie a Te ausiliatrice ed avvocata di questa repubblica.”



TORNA ALLE SCRITTURE
Per chi lo volesse sentire recitato riporto il video dell’esibizione dell’amico Gianni Moi che, con grande pathos, ha ricostruito l’episodio.

L’osella commemorativa coniata in occasione dell’invocazione della Madonna della Salute